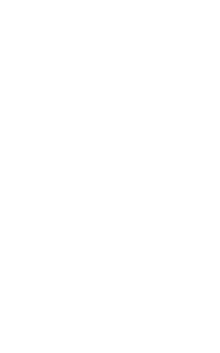È forse questa la cifra che più lo ha distaccato da quel mondo di amicizie fiorentine che pure gli era stato tanto caro e con cui condivise, a modo suo, appunto, un pezzo di cammino; mondo che per noi oggi risulta così importante non soltanto da un punto di vista di storia religiosa e di storia della Chiesa, ma anche di storia della cultura e della politica italiana del secondo dopoguerra.
Successe con Giorgio La Pira, Giuseppe Dossetti, Gianpaolo Meucci, Mario Gozzini, Ernesto Balducci, per quanto riguarda le loro posizioni sia politiche sia ecclesiali.
Padre Serafino Tognetti, che ha potuto conoscerlo per più di vent’anni, seguendolo attivamente nell’esperienza della Comunità dei figli di Dio, ha offerto qualche anno fa ai lettori un profilo biografico che precisa cronologie e, nello stesso tempo, si interroga sui grandi temi spirituali che mossero il padre fondatore della sua Comunità 3.
A distanza di un decennio dalla scomparsa di don Divo, incominciano adesso a comparire studi significativi che vanno a illuminare progressivamente singoli aspetti e relazioni della sua vita 4.
Nel centenario della nascita di don Divo Barsotti, nel 2014, sono state pubblicate alcune lettere di direzione spirituale, i cui destinatari sono persone di ogni categoria sociale e culturale, di diverse età, uomini e donne, fedeli laici e religiosi 5. Si tratta in questo caso di testi «da accostare con attenzione religiosa», come invita a fare il curatore, padre Agostino Ziino nella Prefazione.
Il materiale biografico e autobiografico, nel suo caso, non manca, e in realtà la sua storia umana non è certo ripetitiva, ma ricca di tornanti e di svolte, di decisioni e di accadimenti. E il suo rapporto con la storia, quando lo si studia e lo si scopre man mano in tutti i suoi scritti, va forse rivelandosi più complesso e problematico di quanto talvolta qualche sua affermazione perentoria possa far pensare.
Specialmente nell’Archivio Barsotti della Comunità dei figli di Dio a Settignano, del quale è oggi responsabile padre Agostino Ziino, ma probabilmente sparsi anche nelle altre comunità sorte numerose nel tempo in Italia e all’estero, molti documenti autobiografici o che lo riguardano da vicino sono stati riordinati, altri sono in via di sistemazione.
Sicuramente un ruolo chiave è rappresentato dai suoi diari, sia da quelli pubblicati per sua volontà da diversi editori quando era vivente, sia da quella parte notevole ancora inedita che il suo Archivio conserva.
Il nesso tra la sua esperienza spirituale e la sua esperienza di scrittura letteraria fu intuito presto dal teologo Hans Urs von Balthasar e Barsotti stesso lo ha confermato. È stato ripreso e messo in rilievo a ragione, soprattutto da chi si è accostato ai suoi diari. Senza i diari, e il loro rivelare l’esperienza soggettiva, « primitiva propria » o «di formazione», senza conoscere «il libro drammatico del divenire della sua vocazione» e senza riconoscere in lui la pluralità degli «influssi letterari» non sembrerebbe neanche possibile una reale comprensione delle sue opere teoretiche 6. Opere teoretiche che si sfioreranno appena, sulle quali un po’ si scivolerà, visto l’obiettivo prevalentemente storico-biografico e non teologico del presente lavoro, e il necessario rispetto di competenze che questo comporta.
Bisognerà pertanto tener presente che Barsotti è le sue letture, per sua stessa ammissione. Queste rivelano l’uomo, le sue aspirazioni e le sue inquietudini, fino a costituirne parte sostanziale, vissuta.
Riguardo alla sua complessa scrittura, si può condividere l’osservazione di suor Maria Giovanna Caprini, che individua il genere letterario di Barsotti «tra poetico frammento e paradosso etico » 7.
Ma parlare di lui è anche riferirsi a più mondi culturali e religiosi del Novecento, italiano e straniero, ognuno con le sue ricchezze peculiari e i suoi limiti, di cui siamo oggi eredi.
Desideroso di vita eremitica, di inabissamento mistico, di solitudine, in realtà Barsotti seppe entrare in relazione con molti protagonisti sia della vita religiosa sia della vita culturale della sua epoca, tanto che è inevitabile, ricostruendo la sua vita, selezionarne alcuni per non essere costretti a limitarsi a un elenco.
Per lo stesso motivo si è scelto anche di operare alcuni affondi riguardo alle sue attività di sacerdote e di uomo di cultura. Attingendo specialmente al molteplice materiale autobiografico, si è preferito far risaltare alcuni momenti cruciali della sua vicenda, come appare per lo meno in quello a tutt’oggi edito.
Fra i suoi numerosi diari, cui si è fatto cenno, e che furono in buona parte pubblicati per sua volontà qualche anno dopo la loro stesura e che in alcuni casi sono stati ripubblicati in anni recenti, si è ad esempio dato particolare rilievo a considerazioni, esperienze e meditazioni che emergono negli anni della Seconda guerra mondiale con La fuga immobile, nel biennio 1966-1968 con Battesimo di fuoco, e nel 1977 con il Diario giapponese 8.
È anche vero che bisognerebbe ripercorrere con attenzione tutti i suoi scritti, scavare ancora nella sua vita, per non correre il rischio di operare una lettura riduttiva delle sue posizioni. Un mistico come don Divo esorta ad andare al di là di qualsiasi umanesimo, religioso o laico che sia, ma questa sua convinzione, se vuole intendere il rifiuto netto di un cristianesimo limitato a prassi sociale, un cristianesimo, ci si passi la parola, «di sinistra», dovrebbe altrettanto distaccarsi da qualsiasi richiamo attuato sulla sua opera da un cristianesimo «di destra».
Lo sguardo con cui si ricostruisce questa sua vita spiritualmente intensa accetta perciò il rischio di essere anche «laterale», sperando di riscoprire qualcosa di più e rendere giustizia al protagonista senza essere unilaterale.
Un grazie speciale da parte mia va a padre Agostino Ziino, Mariangela Maraviglia e Milena Carrara Pavan.
Note
1 D. Barsotti, La presenza donata. Diario 1979-1980, Santi Quaranta, Treviso
1992, p. 108.
2 D. Barsotti, Battesimo di fuoco (29 dicembre 1966), Rusconi, Milano 1984, p46.
3 S. Tognetti, Divo Barsotti. Il sacerdote, il mistico, il padre (Prefazione di C. Caffarra), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012.
4 Si veda sul rapporto con Giuseppe Dossetti, G. Dossetti – D. Barsotti, La necessità urgente di parlare. Carteggio 1953-1995 (F. Mandreoli – E. Dondi, edd.), Il Mulino, Bologna 2014; sul rapporto con l’editore Rienzo Colla rimando alla relazione di A. Ziino, Rienzo Colla e don Divo Barsotti, tenuta alla Giornata di studio su Rienzo Colla editore per conto di Dio, giovedì 27 novembre 2014, Vicenza, i cui Atti sono in via di pubblicazione.
5 D. Barsotti, « Amatissimo dal Signore… ». Lettere di paternità spirituale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2014.
6 Cfr. E. Grasso, L’esperienza di don Divo Barsotti attraverso la lettura dei diari, in S. Tognetti – G. Guarnieri – L. Russo (edd.), Cerco Dio solo. Omaggio a Divo Barsotti, Comunità dei Figli di Dio, Settignano (FI) 1994, pp. 17-56 (vedi le citazioni a p. 17). E. Grasso, che esamina nel suo saggio la composizione e il susseguirsi dei diari nella vita di Barsotti, cita in primo luogo la nota Prefazione che il teologo svizzero Hans Urs von Balthasar volle fare all’edizione in lingua tedesca del diario di D. Barsotti, La fuga immobile, che copre il periodo dal 25 maggio 1944 all’8 novembre 1946 (D. Barsotti, La fuga immobile. Diario spirituale, Edizioni di Comunità, Milano 1957; 2a edizione: Premessa di A. Ziino, San Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2004). Si veda pertanto H.U. von Balthasar, Einfubrung des Herausgebers, in D. Barsotti, Die regungslose Flucht. Ein geistliches Tagebucb, Johannes Verlag, Einsiedeln 1960. Tale Prefazione è stata tradotta in italiano nel citato libro di S. Tognetti – G. Guarnieri – L. Russo (edd.), Cerco Dio solo (H.U. von Balthasar, Introduzione a «La fuga immobile», pp. 5-16). Sui diari di Barsotti, si veda poi la più recente e complessiva ricerca di S. Albertazzi, Sull’orlo di un duplice abisso. Teologia e spiritualità monastica nei diari di Divo Barsotti, San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2009.
7 Cfr. M.G. Caprini, Il contributo di Divo Barsotti al movimento liturgico. La tematica liturgica in un’opera del pre-Concilio, in S. Tognetti – G. Guarnieri – L. Russo (edd.), Cerco Dio solo, p. 124.
8 D. Barsotti, Diario giapponese, Morcelliana, Brescia 1979.